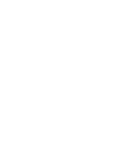Alla fine del secolo IX, infatti, i beni erano posti a circa 25 km da Pomposa, ora ne troviamo molti situati a più di 70 km di distanza, sia nell’area meridionale, sia in quella nordoccidentale dell’esarcato. Però non dobbiamo farci ingannare dalla diversificazione dei beni e dalla dimensione regionale perché il patrimonio di Santa Maria, composto da vari fundi e da alcune saline (di cui non conosciamo l’esatto numero) risulta comunque di modeste dimensioni se confrontato con quello di un coevo monastero regio, che poteva annoverare fino a una decina di curtes o massae, grandi proprietà fondiarie composte da numerosi fundi, oltre che altri monasteri dipendenti, castra, cioè villaggi fortificati, e diritti fiscali, come quello sui mercati.
La comparazione è lecita perché proprio a questo periodo, più precisamente alla metà degli anni ‘80 del X secolo, risale un documento che permette di sciogliere i dubbi sullo statuto istituzionale di Santa Maria di Pomposa, dimostrando che aveva assunto, con certezza, la fisionomia di monastero. Si tratta della donazione redatta a Comacchio il 1° dicembre 986, giunta sino a noi in originale, tramite cui Albina, con il consenso del marito Pietro, cedeva una casa cum solo terre et curticella sua e un orto, siti a Comacchio, a Martino, prete, monaco e abate del monastero di Santa Maria di Pomposa. Entrambi i beni, si specifica nella carta, erano appartenuti a Luliano, diacono e monaco del medesimo monastero, e venivano ceduti proprio per la salvezza dell’anima del defunto monaco [Mezzetti, Carte di Pomposa, n. 30, pp. 65-68]. L’elemento che permette di sciogliere ogni dubbio sullo forma istituzionale assunta da Pomposa, almeno a partire da questi anni, è l’uso del termine monachus per indicare la condizione ecclesiastica sia di Martino, sia di Luliano. Infatti, se il termine monasterium, come abbiamo visto nella scheda precedente
(scheda 1), aveva una certa ambiguità nei secoli altomedievali perché poteva indicare tanto una semplice chiesa quanto un monastero, nel X secolo il termine monachus ha interpretazioni assolutamente univoche: indica sempre il membro di una comunità monastica, che poteva anche assumere compiti del clero secolare, come in questo caso il ruolo di diacono o di prete, ma rimaneva comunque vincolato alla vita cenobitica. Questa donazione rappresenta la prima attestazione nelle fonti scritte della presenza di monaci appartenenti alla comunità di Santa Maria di Pomposa, e proprio a partire da questo momento le menzioni si ripetono: in tutti i pochi documenti relativi al nostro monastero, sia originali, sia copie realizzate in un periodo successivo, datati fra la fine del X e l’inizio dell’XI secolo l’abate è sempre indicato anche come prete e, soprattutto, come monachus.
A questo punto, rimangono da chiarire le modalità e le ragioni per cui il monastero di Pomposa è entrato a far parte del patrimonio di San Salvatore. In assenza di un documento – una donazione o una permuta, per esempio – che attesti in modo diretto questo passaggio, è necessario allargare lo sguardo e ricostruire il processo di affermazione del potere ottoniano nell’esarcato durante la seconda metà del X secolo, prestando particolare attenzione al ruolo svolto dall’imperatrice Adelaide.
Quando, nel 962, Ottone I si fece incoronare imperatore a Roma da papa Giovanni XII, giurò solennemente che avrebbe restituito l’esarcato e la pentapoli al pontefice, proprio come aveva promesso Carlo Magno all’indomani della conquista del regno longobardo nel 774. Ma proprio come il primo imperatore carolingio, anche Ottone I non mantenne in concreto la promessa fatta. Nei primi anni, vi furono sicuramente ragioni militari che gli impedirono di adempiere al giuramento: le aree meridionali dell’esarcato e la pentapoli furono zone di strenua difesa all’invasione ottoniana iniziata nel 961, tanto che il re italico Berengario II si rifugiò proprio nella rocca di San Leo, ancora oggi svettante nell’entroterra di Rimini, dove fu costretto a capitolare solo alla fine del 964. Anche se Adalberto di Magonza, autore molto vicino all’imperatore, afferma che Ottone restituì l’insieme di quelle terre al papa nel 967 [Adalberti Continuatio Reginonis, p. 178], è molto probabile, invece, che quest’ultimo abbia mantenuto un saldo controllo su almeno una parte dell’esarcato. Tutte le fonti, infatti, sono concordi nell’attestare che durante le varie spedizioni compiute in Italia fra il 961 e il 972 Ottone soggiornò molto spesso e per lunghi periodi a Ravenna. Inoltre, è molto probabile che fra il 967 e il 971 Ottone fece costruire un palazzo imperiale nel suburbio meridionale di Ravenna, fuori porta Porta San Lorenzo, anche se l’edificio non è stato ancora rinvenuto dagli archeologi, come ricorda Enrico Cirelli, che pure ritiene attendibile la notizia. I soggiorni frequenti e la costruzione di una residenza che mostrasse materialmente la “presenza” dell’imperatore anche quando Ottone non si trovava in città sono attestazioni di una volontà specifica di controllo su Ravenna e quindi, di conseguenza, sull’esarcato. Una volontà che viene confermata, anzi rafforzata, dalla concessione ad Adelaide dell’insieme dei diritti pubblici, cioè il districtus, l’intera linea di costa, la moneta, il teloneo, il mercato, le mura e le porte della città di Ravenna, insieme con il possesso dell’intero comitato di Comacchio, in cui – è bene ricordarlo – sorgeva Santa Maria di Pomposa. Non possediamo un documento che attesti in modo diretto tale concessione, ma è possibile dedurla da un privilegio pontificio, con cui nel 998 papa Gregorio V assegnò quei diritti e quei beni a Gerberto d’Aurillac, il futuro papa Silvestro II, che in quel momento era arcivescovo di Ravenna, precisando che tale concessione sarebbe stata effettiva solo dopo la morte di Adelaide [Zimmermann, Papsturkunden, n. 354, pp. 689-692]. È dunque evidente che l’imperatrice detenesse i diritti pubblici – che prevedano anche introiti economici – sul principale centro politico dell’esarcato e il controllo diretto su un territorio – quello di Comacchio – di notevole ricchezza, sia per la presenza di grandi massae e di numerose saline, sia per il controllo del delta del Po, punto d’arrivo della principale arteria commerciale del regno italico e snodo per gli scambi fra la pianura padana e il mar Adriatico.
La penetrazione del potere ottoniano nell’esarcato, incarnato dall’azione congiunta di Ottone I e Adelaide, sembra sia avvenuta in pieno accordo con il principale attore politico dell’area, l’arcivescovo di Ravenna Pietro. Fin dall’arrivo di Ottone in Italia nel 961, l’arcivescovo Pietro si schierò apertamente a favore del futuro imperatore e forse fu anche questa scelta di campo una delle ragioni della rivolta scoppiata nel 966 a Ravenna, durante la quale una parte dell’aristocrazia cittadina guidata dal diacono Rainerio saccheggiò il palazzo arcivescovile e imprigionò Pietro. Ma grazie all’intervento militare di Ottone, l’arcivescovo fu presto liberato e reinsediato sulla cattedra ravennate, mentre l’anno successivo, in un solenne placito tenutosi a Ravenna e presieduto congiuntamente dall’imperatore e dal papa, Rainerio fu condannato alla confisca di tutto il suo ingente patrimonio – era infatti un discendente della comitissa Engelrada – che fu contestualmente assegnato alla chiesa ravennate. Nel 971, però, Pietro lasciò la cattedra arcivescovile, si ritirò in monastero e sparì dalla scena politica ravennate: è possibile che questa scelta fosse dettata da motivi di età, visto che ricopriva quel ruolo dal 927, ma è possibile anche, come ritiene David Warner, che egli sia stato costretto a farsi da parte da quella stessa fazione dell’aristocrazia ravennate, che pochi anni prima lo aveva imprigionato. Infatti, al suo posto fu eletto Onesto, esponente di una delle principali famiglie dell’élite ravennate, che riprese con forza la politica di larghe concessioni di terre ecclesiastiche ai membri dell’aristocrazia esarcale. Onesto mantenne sicuramente buoni rapporti con Ottone I e con il suo successore Ottone II, ma l’avvicendamento con Pietro, fedelissimo alla causa imperiale, e il ritorno a dinamiche più “collegiali” nella gestione dell’esarcato da parte del nuovo arcivescovo potrebbero aver spinto Ottone I e Adelaide ad affidare il controllo di alcuni beni – per esempio, il monastero di Santa Maria di Pomposa – a mani ritenute più affidabili, come un monastero regio sotto il loro diretto controllo.
Proprio negli anni Settanta del X secolo, forse fra il 971 e il 972, Adelaide fondò a Pavia il monastero regio di San Salvatore fuori le Mura dotandolo riccamente con beni propri ma di chiara origine fiscale. È dunque probabile che sia proprio questo il momento in cui, tra gli altri beni confluiti nella nuova fondazione pavese, anche Santa Maria di Pomposa sia entrata nel patrimonio di San Salvatore, con l’obbiettivo di assicurare al controllo imperiale un monastero dalla posizione strategica, un obbiettivo che divenne ancora più chiaro con l’azione di Ottone III.
(scheda 3)