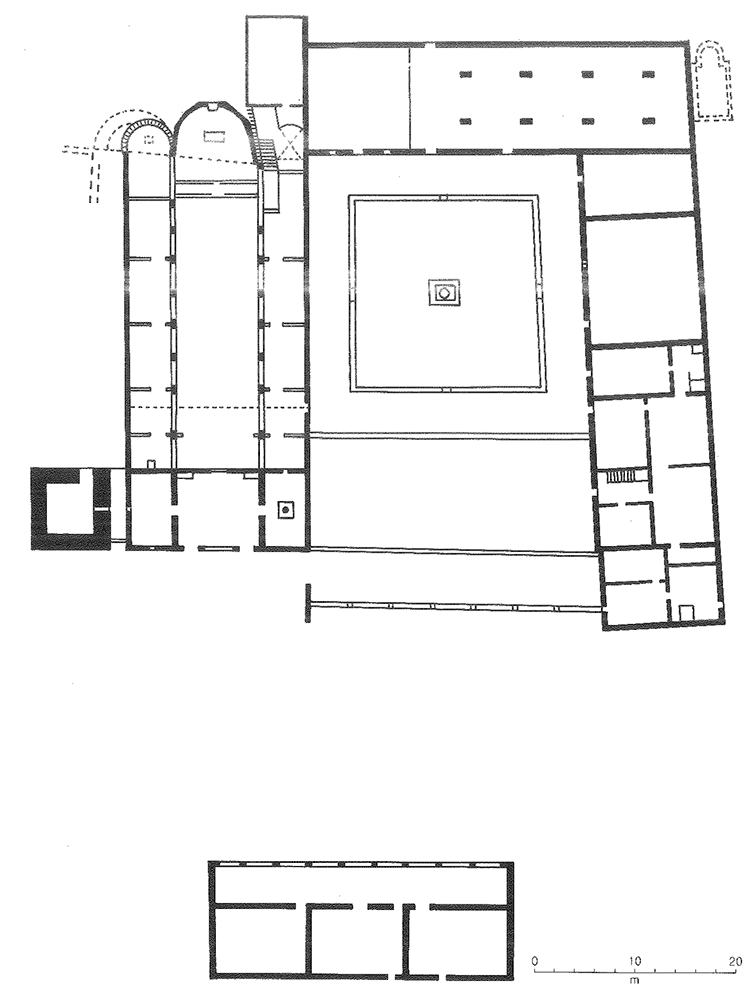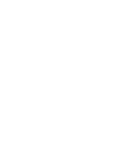La nascita del monastero di Santa Maria di Pomposa non è attestata da alcuna fonte scritta.
Non è giunto fino a noi un diploma di fondazione da parte di un re, un imperatore o di un laico potente, come invece è avvenuto per molti altri monasteri medievali. Non ci è giunta nemmeno una cronaca del monastero, che almeno retrospettivamente getti luce sulle origini di Santa Maria di Pomposa. Non si è conservato, se mai è esistito, un catalogo dei primi abati, cioè una lista con i loro nomi, alcuni dati biografici e pochi avvenimenti coevi particolarmente importanti, che in molti altri casi ha permesso di ricostruire, per quanto in modo scarno, i primi passi di un cenobio. Il caso di Santa Maria di Pomposa, però, non è né raro, né eccezionale: sono numerosi, infatti, i monasteri sorti durante l’altomedievo le cui origini rimangono ancora oggi oscure.
Dunque, la storia del monastero comincia in medias res: quando vediamo comparire per la prima volta Santa Maria di Pomposa nelle fonti scritte il monastero ha già percorso un tratto della sua vita, di cui però non conosciamo la lunghezza. La prima attestazione documentaria dell’esistenza di Santa Maria di Pomposa è un frammento di lettera inviata da papa Giovanni VIII all’imperatore Ludovico II il 29 gennaio 874, giunto fino a noi solo perché il cardinale Deusdedit, il principale giurista attivo a Roma durante il pontificato di Gregorio VII, lo inserì nella sua Collectio canonum, un importante trattato di diritto canonico redatto alla fine dell’XI secolo [Fragmenta registri Iohannis VIII papae, in MGH Epistolae Karolini Aevi V, n. 31, p. 291].
Nel frammento, Giovanni VIII rivendica come proprietà della chiesa romana i monasteria di Santa Maria di Pomposa, di San Salvatore in Montefeltro e di San Probo, di cui non specifica l’ubicazione; rivendica inoltre la proprietà dei contadini e dei beni fondiari presenti nei territori di Ferrara e Adria (le aree a ovest e a nord di Pomposa), così come di Galeata e Fantella (località dell’appennino forlivese, situate appena a nord del Montefeltro). Le rivendicazioni di Giovanni VIII, dunque, si riferiscono a due aree precise: l’una a nord e l’altra a sud dell’esarcato, ma ai fini della storia di Pomposa l’aspetto più rilevante è che i coloni e le proprietà fondiarie non compaiono come dipendenze dei due monasteria vicini, bensì come beni indipendenti. Il frammento quindi non fornisce alcuna indicazione sul patrimonio di Santa Maria di Pomposa a quel tempo.
Rimane da svelare contro chi il papa rivendicava quei possessi. Nel frammento, Giovanni VIII è molto esplicito a riguardo perché indica più volte l’arcivescovo di Ravenna: dal testo si intuisce che l’arcivescovo aveva protestato presso l’imperatore per le ingerenze papali e quindi il pontefice ribadisce con forza che quei beni erano di pertinenza romana, già proprietà dei papi da molto tempo. Questo documento rientra fra le molte testimonianze del conflitto che, fin dalla metà dell’VIII secolo, vide contrapposti i pontefici romani e gli arcivescovi di Ravenna per il controllo dell’esarcato e della pentapoli in generale, nonché di singoli beni presenti in quei territori, probabilmente di origine fiscale e cioè di proprietà imperiale in età tardoantica. I papi basavano le loro pretese sulla presunta concessione alla chiesa romana dell’esarcato e della pentapoli da parte di Pipino, re dei Franchi, rinnovata poi da suo figlio Carlo Magno, mentre gli arcivescovi di Ravenna si presentavano come gli eredi dell’esarca, cioè l’alto funzionario bizantino che aveva governato l’area fino alla conquista longobarda del 751, rafforzando così un controllo di fatto derivato dalla loro presenza sul territorio.